“La cospicua presenza nell’appennino parmense di maestà (da Divinae Maiestatis Sacratum, con cui si era soliti, fin dalle origini del Cristianesimo, indicare la costruzione dedicata a Dio) affonda le sue radici nell’antica consuetudine cristiana di porre le strade e chi le percorresse, i campi, i villaggi, le case, sotto la protezione di qualche deità.
Le maestà, oltre che esprimere, almeno in queste valli, uno dei momenti più alti e sentiti della religiosità popolare, costituiscono l’ultima forma di consacrazione del territorio, attraverso la devozionalità cristiana, contro le forze ritenute avverse.
Con il rinnovamento edilizio che investe, in quest’area appenninica, l’edilizia civile fra il XVI e il XVII secc., le immagini devozionali, ospitate in tabernacoli e edicole appositamente edificati, si moltiplicano e vengono poste sulle porte delle case, delle stalle, dei seccatoi (dove, oltre che ad indicare la pietà dei committenti, potevano servire come marchio di proprietà e come segno di discreta agiatezza), ai crocicchi delle strade, nei luoghi eminenti del paesaggio naturale, nei campi lavorati, all’imbocco dei ponti, a costituire precisi punti di riferimento nella viabilità antica, di cui ancora oggi resta traccia nei toponimi locali.
A seconda della loro destinazione e collocazione originaria, le maestà … si distinguono in tre precise categorie:
- maestà delle abitazioni;
- maestà delle strade;
- maestà delle fonti.
Al rapporto utilitario col Sacro si affianca un atteggiamento disinteressato, di cui costituiscono testimonianza privilegiata i numerosissimi tabernacoli dedicati alla Madonna sotto molteplici titoli, alcuni dei quali esprimono un arcaico senso di solidarietà uomo/ natura (Cfr.: Beata Vergine della Neve; Beata Vergine dei Quercioli), e le cui epigrafi esprimono spesso un monito domestico e affettuoso (come recita il motto, frequentissimo, “A nessuno grave sia/ dir passando/ AVE MARIA”).
Accanto alla Madonna troviamo rappresentato tutto un calendario liturgico contadino, fatto di santi “specialisti”, protettori di particolari settori della vita e del lavoro: per lo più maschi, come si confà ad una cultura contadina, sono santi terapeuti e taumaturghi o, comunque, attenti alla salute ed ai bisogni di un piccolo mondo di pastori e contadini:
Sant’Antonio da Padova, il santo del pane, sempre il più effigiato (solo o associato con altri);
S. Antonio Abate, protettore degli animali da cortile ed invocato contro l’”herpes zoster”, la peste, lo scorbuto e l’afta epizootica;
S. Rocco, protettore degli spaccapietre, misero mestiere tanto diffuso in questi monti, invocato contro la silicosi e la peste;
e poi S. Francesco d’Assisi, S. Giuseppe e S. Lorenzo martire.
Numerose, comunque, anche le maestà raffiguranti i santi cari ad un universo devozionale popolare per le leggende fiorite intorno alla loro “Passio”: Barbara, Caterina da Siena, Fabiano e Sebastiano, Emidio, Genesio, Valentino.
Le maestà sono frutto dell’opera oscura, paziente (e non di rado elevata) di ignoti scalpellini lunigianesi che, a piedi o a dorso di mulo, giungevano alle Corti di Monchio attraverso i difficili passi del confine, recando formelle già predisposte, o da scolpire ex-novo, a seconda delle esigenze dei committenti.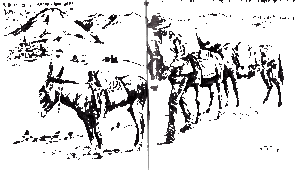
Disegno di Kara Pintòr
Ospitate dalle famiglie di più agiata condizione, queste maestranze si accontentavano del solo vitto e alloggio e, probabilmente, si adattavano a svolgere durante la loro permanenza altri lavori di scalpello, utilizzando la cosiddetta “arenaria macigno” (a grana grossa ed elevato tenore siliceo, di non facile lavorazione) che si trovava abbondante nella “Cava di Piagnola” a circa tre miglia SUD/ OVEST di Rigoso, ricordata dal Boccia nel suo viaggio, compiuto nel 1804 “ai monti di Parma” (Boccia A., Viaggio ai monti di Parma, in Quaderni parmigiani, 1970, n. 2, p. 36).
Alcune fra le più antiche maestà, raggiungono effetti ragguardevoli considerata la povertà del materiale e della committenza, ma tutte, dalle più antiche alle più recenti, ricalcano uno schema compositivo fisso e pressoché invariato, frutto presumibilmente di una tradizione artistica già consolidata.
Le formelle sono, a larga maggioranza, anonime, sebbene vi appaia spesso evidente la volontà, da parte dell’ignoto marmorino, di caratterizzazione personale dell’opera, ad esempio attraverso un uso insolito o poco ortodosso delle abbreviazioni paleografiche, o mercé l’inserimento di minuscole insegne araldiche, alludenti alla committenza locale.”
(testo di Anna Mavilla)
